Ricordiamo Bruno Borghi – prete-operaio, sindacalista, amico di Enzo Mazzi e Sergio Gomiti e della Comunità dell’Isolotto, contadino, cooperante in Nicaragua e militante a fianco dei disabili, dei poveri, dei detenuti di Sollicciano.
Ripercorriamo le sue scelte di vita e riflettiamo sul suo pensiero attraverso:
1) due articoli, uno di Valerio Gigante pubblicato su Adista n.44 del 11.12.2021 e l’altro di Carlo Giorni pubblicato su Il Fatto Quotidiano dell’8.12.2021, che riportamo qui poco più avanti;
2) il libro di Antonio Schina: “Bruno Borghi. Il prete operaio” (Centro di Documentazione Pistoia Editrice, Pistoia, 2017) presentato in Comunità il 5 novembre 2017 . Nel corso dell’Assemblea sono intervenuti Antonio Schina e Mario Lancisi; si è anche ricordato l’intervento che Borghi fece all’assemblea dell’Isolotto dell’11 gennaio 1969 quando la Comunità stava decidendo come vivere la situazione difficile che aveva di fronte. Si è inoltre letta la preghiera scritta da Bruno per la notte di Natale del 1976, quando era ancora a Quintole. L’intervento e la preghiera sono riportatti nel fascicolo.
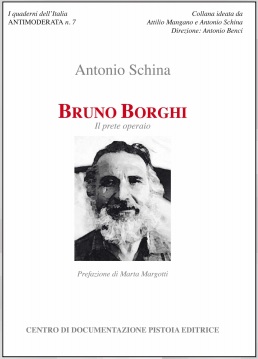
3) il libro di Beniamino Deidda “Basta un uomo: Bruno Borghi, una vita senza padroni” (Edizioni Piagge, Firenze, 2021) presentato in Comunità nella Assemblea del 14 novembre 2017. Nel corso dell’Assemblea sono intervenuti Beniamino Deidda e Gianni Ricciarelli. L’intervento di Ricciarelli e riportato nel fascicolo qui allegato.

Don Bruno Borghi, l’operaio-prete “senza padroni” – di Valerio Gigante – Adista Documenti n° 44 del 11/12/2021
DOC-3158. ROMA-ADISTA. Prete operaio, o operaio prete? Nel caso di don Bruno Borghi certamente la seconda opzione. Nel senso che Borghi diventò prete per abbracciare una scelta di classe, che per lui era radicata nel Vangelo; per questa scelta decise di lavorare in fabbrica, poi come contadino; in seguito con i sandinisti in Nicaragua; e ancora con i detenuti del carcere di Sollicciano. E quando si accorse che questa scelta di classe non solo non era abbracciata dalla Chiesa di cui era presbitero, ma in molti casi era addirittura osteggiata – perché la Chiesa, in una temperie politico-culturale gravida di trasformazioni, abbracciava le istanze dei ceti dominanti – preferì abbandonare la Chiesa.
Di Bruno Borghi si è scritto poco (anche perché Borghi ha lasciato davvero poco di scritto, rispetto alla mole del suo impegno ecclesiale e politico). C’è un numero monografico della rivista Pretioperai, il 72-73 del gennaio-aprile 2007; poi un meritorio libro del 2017 (Bruno Borghi. Il prete operaio, di cui Adista ha parlato ampiamente) di Antonio Schina ha riproposto questa importante figura ecclesiale di quella stagione che Giorgio La Pira definì la “germinazione fiorentina”. Arriva ora un volume più ampio edito dalla casa editrice della Comunità delle Piagge, il cui animatore, don Alessandro Santoro, è un prete cresciuto proprio nella stagione ecclesiale successiva ai fermenti che avevano animato la Chiesa fiorentina nel periodo pre e post conciliare. A partire dal fondamentale magistero di don Milani; passando per Turoldo e La Pira; don Facibeni e don Rosadoni, don Mazzi e p. Balducci. E, appunto, don Bruno Borghi, meno conosciuto ma non per questo meno centrale nello sviluppo delle istanze di un cattolicesimo sociale e progressista.
Il libro lo ha scritto Beniamino Deidda (Basta un uomo. Bruno Borghi. Una vita senza padroni, prefazione di Tomaso Montanari, Edizioni Piagge, 2021, euro 14), ex procuratore capo a Firenze, vicino alla Comunità dell’Isolotto fin dalla fine degli anni ‘60 (un suo intervento, durante una delle infuocate assemblee di quegli anni, gli costò problemi nella carriera in magistratura). Deidda ha raccolto documenti e testimonianze su Borghi, cercando di ricostruirne il profilo umano ed ecclasiale.
Una vita alla “frontiera”
Nato nel 1922, don Borghi fu ordinato prete alla fine degli anni ‘40: nel seminario di Firenze era stato compagno di don Lorenzo Milani, con il quale conservò una profonda amicizia. Di Borghi (di circa un anno più vecchio di lui) Milani aveva una stima grandissima e a Borghi – di cui ammirava la scelta radicalmente e integralmente di classe – sottoponeva molte delle sue idee per avere consiglio e supporto.
Già nel 1950, infatti, Borghi aveva voluto lavorare in fabbrica; anzi, lavorò in diverse fabbriche fiorentine, impegnandosi anche a livello sindacale. E pensava alla sua attività in fabbrica come un modo per agevolare il collegamento tra la classe operaia e altri soggetti sociali di trasformazione, le donne, gli studenti, i preti e i cristiani impegnati nel territorio e nelle parrocchie più avanzate.
Appena ordinato prete, Borghi chiese infatti di andare a lavorare in fabbrica. Non lo ottenne e si fece allora nominare assistente delle Acli, per stare comunque a fianco dei lavoratori; poi con uno stratagemma (un tirocinio alla fine di un corso per Esperti del lavoro e Assistenti Sociali, organizzato dall’Università di Firenze) riuscì nel 1950 a entrare in una delle maggiori realtà industriali di Firenze, il Pignone. Durò poco e il card. Dalla Costa fu costretto dalle pressioni provenienti da Roma a spostarlo a fare il cappellano nel carcere minorile. La sua denuncia dei metodi violenti utilizzati dal direttore del carcere nei confronti dei ragazzi lì detenuti fece però esplodere uno scandalo. E Borghi dovette tornare a incarichi parrocchiali. Nel 1957 è alla parrocchia fiorentina di Sant’Antonio al Romito come cappellano. La chiesa si trovava nel mezzo di un quartiere operaio, vicinissimo a Rifredi. Non lontano dalla chiesa c’era la “Galileo”, la seconda grande fabbrica metalmeccanica dopo il “Pignone”. Nel 1958 la “Galileo” aveva deciso di licenziare quasi un migliaio di lavoratori. La fabbrica fu occupata per diciotto giorni e dopo lo sgombero, centocinquanta operai e sindacalisti finirono sotto processo. Tra questi c’era anche don Bruno, rinviato a giudizio per istigazione a delinquere perché era stato con gli occupanti e aveva difeso l’occupazione definendola «un atto rispondente in pieno alla morale evangelica».
Il successore di Dalla Costa, il card. Ermenegildo Florit, spedì Borghi a fare il parroco a Quintole, frazione del comune di Impruneta. Del resto, don Bruno era diventato ormai una spina nel fianco della Curia, perché era tra i preti più intransigenti nel contestare la linea conservatrice intrapresa dall’arcivescovo Florit dopo gli anni di rinnovamento segnati dalla presenza del card. Costa. Borghi comunque (come il suo amico don Milani dall’esilio di Barbiana) non si fermò: ancora prima di don Milani denunciò l’ambiguo ruolo dei cappellani militari a difesa dell’obiezione di coscienza, scrivendo una Lettera aperta ai cappellani militari di poco precedente alla più famosa Lettera di don Lorenzo. Poi, alla fine del 1968, fu al fianco di un altro ex compagno di seminario, don Enzo Mazzi, che la Curia aveva cacciato dalla parrocchia dell’Isolotto insieme a don Paolo Caciolli.
In quel periodo don Sergio Gomiti, che all’Isolotto era stato come vicario di Mazzi e poi era stato nominato parroco della Casella (periferia di Firenze), diede le dimissioni dichiarandosi corresponsabile delle accuse che avevano portato all’allontanamento dei preti dell’Isolotto. La stessa cosa, poco dopo, fece anche don Bruno Borghi da Quintole. Nel 1968, intanto, Borghi era stato assunto alla Gover, fabbrica specializzata nel settore dei manufatti di gomma per l’edilizia e l’abbigliamento. «Un lavoro impegnativo come operaio, una fatica aggravata dai turni di lavoro notturno, una vicenda che si snoda attraverso lotte sindacali durissime, fatta di licenziamenti, cause di lavoro, riassunzione in fabbrica e processi per vilipendio della magistratura», racconta nel libro Deidda: «Fare l’operaio alla Gover ebbe anche l’effetto di rendergli chiaro che la partita decisiva non si giocava per lui dentro la Chiesa, ma in uno spazio sociale e umano che era del tutto estraneo alle questioni ecclesiastiche. Non era un caso che pochi mesi dopo l’assunzione, nel dare le sue dimissioni da parroco, avesse scritto al cardinale: «L’attuale condizione di parroco è in contrasto con la mia decisione di essere operaio». Era la fine di una parabola che lo aveva tormentato, ma i cui termini erano ora più chiari: la decisione di essere operaio non voleva dire solo avere un posto di lavoro, avere un mestiere e i mezzi per mantenersi, lui e la madre. Era invece una scelta di campo: vivere con i compagni operai dentro la fabbrica ciò che non era stato possibile vivere dentro la Chiesa.
Dopo le dimissioni da parroco, peraltro, il card. Florit gli aveva chiesto di continuare a officiare la messa, lasciando l’uso della canonica a lui e alla anziana madre. Nel 1981 Borghi abbandonò definitivamente il ministero, per andare a fare il contadino nella zona di Torri, nelle colline di Firenze. Nel frattempo aveva conosciuto Agnese, che divenne sua moglie e da cui, nel 1990, ebbe un figlio, Giovanni. Negli anni ‘80 si recò più volte in Nicaragua per lavorare, come cooperante, per dare il suo contributo alla costruzione dell’hombre nuevo che la rivoluzione intendeva realizzare, attraverso «la lotta di un popolo intero che accompagnava il recupero della libertà con istituzioni pacifiche e aperte». Poi fu volontario in carcere. Morì nel 2006, a Torri, dove viveva con la sua famiglia facendo il contadino e dove è stato sepolto.
La storia dei preti operai è tornata di moda (soprattutto in libreria): da don Bruno Borghi a don Renzo Fanfani, ecco chi erano – di Carlo Giorni – Il Fatto quotidiano – 8 dicembre 2021

L’esperienza dei sacerdoti-lavoratori è stata al centro di un seminario a San Gimignano, “Indifferenti mai”, che ha messo in luce la rottura con la Chiesa ma anche la radicalità in conflitto con la sinistra riformista. Nel segno di “una vita senza padroni”
Ugolino, patron della Gover, un’azienda di pneumatici, e presidente della Fiorentina dal 1971 al ’77 (fu lui ad acquistare Giancarlo Antognoni), incede solenne e padronale nella sua fabbrica tra gli operai che ossequiosi gli danno la mano, meno uno, don Bruno Borghi, un prete operaio. “E tu perché non ti alzi e non mi dai la mano?”, lo fulmina Ugolini. Il prete ribelle risponde lapidario che lui la mano la porge a chi gliela dà. In breve: non riconosce il padrone, non accetta inchini e ossequi. Conclusione inevitabile: don Borghi, detestato da Ugolini e un po’ anche da un sindacato tiepido che non vede di buon occhio le iniziative del prete operaio, viene licenziato. La magistratura poi però gli dà ragione e lo fa riassumere.
L’episodio è stato raccontato da Beniamino Deidda, magistrato, già procuratore generale della Toscana, autore del libro Bruno Borghi. Una vita senza padroni, con prefazione di Tomaso Montanari, e presentato a San Gimignano nel corso del seminario, “Indifferenti mai. La testimonianza dei preti operai nella Toscana terra di diritti”, organizzato dal Centro internazionale di studi sulla religiosità contemporanea, di cui quella dei preti operai è stata, almeno nella seconda metà del Novecento, un’esperienza che rompe con la Chiesa tradizionale e che nella sua radicalità viene spesso in conflitto con la sinistra riformista. Nel segno appunto di “una vita senza padroni”, come recita il titolo del libro di Deidda.
L’idea di dedicare un seminario ai preti operai, ha spiegato il presidente del Centro, il sociologo Arnaldo Nesti, è nata dalla fioritura nel 2021 di diversi libri dedicati a figure di preti operai, soprattutto in Toscana, terra ricca di sacerdoti in tuta, anche per la presenza, ha spiegato lo storico Pietro Domenico Giovannoni, di presenze progressiste come Giorgio La Pira, il cardinale Elia Dalla Costa e don Luigi Facibeni. Così in terra toscana sbocciano le esperienze di don Beppe Pratesi, don Renzo Fanfani fino a don Sirio Politi, che nel 1956 decise di farsi prete operaio e fondò a Viareggio una piccola comunità con altri due preti, don Beppe Socci e Luigi Sonnenfeld, dedicandosi soprattutto alla lavorazione del ferro. La chiesetta della comunità si trova nella darsena viareggina, tra i cantieri e i pescatori del canale Burlamacca, e oggi ci vive solo don Luigi perché nel frattempo don Sirio e don Beppe sono morti.
L’esperienza dei preti operai nasce in Francia subito dopo la guerra. Tra i più noti il domenicano Jacques Loew, che lavorò come scaricatore di porto a Marsiglia e il prete Michel Favreau, morto in un incidente sul lavoro. Il movimento dei preti operai si estende a molti Paesi europei, compresa l’Italia, dove la prima tonaca ad indossare la tuta è stato don Borghi, compagno di seminario di don Milani e forse l’amico più vicino, che nel 1950 entrò operaio alla Pignone, nonostante i divieti di Pio XII e della Curia fiorentina. Dopo anni di esperienze operaie (divenne attivista della Cgil) e di dissensi ecclesiali, nel 1970 don Borghi abbandonò la tonaca e si sposò. Morirà nel 2006 portandosi dietro, anche negli avversari, la stima per la sua coerenza. “Non amava essere definito un prete operaio. Gli sembrava un privilegio. Si sentiva solo un operaio. La sua è stata la scelta di vivere tra gli ultimi”, ha sottolineato Deidda.
Altra figura di spicco del movimento dei preti operai è stato don Renzo Fanfani (biografia scritta da Paola Sani e edita da Gabrielli editore), nato nel 1935 e morto quattro anni fa, “un gran personaggio, poteva fare il sindaco, il vescovo, gran carisma”, ha ricordato Nesti. Quando nel 2006 il governo Berlusconi prova a cambiare alcuni articoli della Costituzione, don Fanfani inscena una singolare protesta: dal campanile della sua chiesa, parrocchia di Avane, a Empoli, espone quattro striscioni rossi con la scritta “No”. E in giallo: “La Chiesa non può rimanere neutrale di fronte al referendum costituzionale”. A tutti i ragazzi che passavano la cresima consegnava due libri: il Vangelo e la Costituzione. Le due bibbie, religiosa e civile.
E nel 2006 per il centenario della Cgil, don Fanfani confessa, in un ritratto video realizzato da Maria Zipoli e Giuseppe Onorati, l’esigenza di “fare scelte più radicali: dovrei di nuovo buttare il cappello per aria”. Buttare il cappello per aria: il tratto distintivo delle esperienze di questi preti operai. C’è chi sogna di studiare sociologia a Trento con Renato Curcio e si ritrova operaio in un’azienda di scarpe. Chi come il fiorentino don Fabio Masi va a fare il facchino: “Da parroco uno avverte la potenza del ruolo, da facchino deve solo eseguire ordini”. O Beppe Pratesi che un giorno non gli basta fare il prete operaio, ma decide di sposare Lucia Frati, come racconta ad Antonio Schina in Con tutto l’amore di cui siamo capaci. La coppia ha oggi 5 figli e lui, Pratesi, 90 anni, si commuove a raccontare, in una San Gimignano fredda e piovosa, i tanti cappelli tirati per aria.
